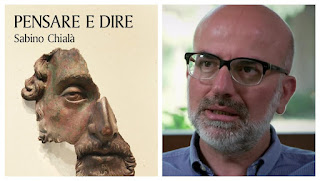Sabino Chialà "Il fondamento della parresia"
|
|
|
|
|
|
|
Una seconda considerazione riguarda il fondamento di una tale parresia o la via per cui
è possibile ricercarla. Come tutti i carismi, in
un’ottica cristiana, anche la parresia è dono di
Dio ed è frutto di ascesi. Essa è dono dello Spirito poiché, come dicevo riferendomi al quarto
vangelo, è il Paraclito che conduce sulla via della
verità, in un progressivo svelamento delle cose
dette da Gesù. Ma è anche frutto dell’impegno
umano, che coopera con lo Spirito e acconsente
al suo agire.
Più concretamente, la parresia nelle relazioni
interpersonali passa attraverso le altre due forme di parresia che abbiamo visto emergere nei
testi biblici: la parresia con sé stessi e la parresia davanti a Dio. Alla prima diamo il nome di
“libertà da sé” e alla seconda quello di “fiducia in Dio”. Detto altrimenti, quella verità vivente che siamo chiamati a esercitare nelle nostre
relazioni ha due sostegni o fondamenti che la
rendono possibile.
Il primo è la qualità della relazione con sé stessi, che dev’essere di libertà.
Il secondo è la relazione con Dio, in cui è necessaria la fiducia.
Del primo tratto troviamo due esempi eminenti nel Battista e in Gesù. Ambedue sono rigorosi con sé stessi, nel senso che conoscono e
aderiscono lealmente alla propria vocazione, senza usurpare né desiderare il posto e la missione
altrui, come Giovanni che afferma con forza di
non essere il Messia (cf. Gv 3,27-30), o come
Gesù che accetta di portare a compimento la sua
missione, pagandone il prezzo. Tale verità con
sé stessi, che è una forma di libertà dalle false
pretese cui gli esseri umani sono soggetti, rende
audaci e capaci di una parresia autentica, che
non degenera in spavalderia né in disprezzo, perché è pagata a caro prezzo. È infatti impossibile
dire la verità all’altro se non si è interiormente
liberi, se si hanno ancora cose da difendere o
da nascondere. Ricordiamo la parola di Gesù: “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”
(Gv 8,32). Il rapporto vale nelle due direzioni: la
verità rende liberi, ma è la libertà interiore che
mette in condizioni di dire la verità.
Ostacolo alla parresia è il fare riserve di sé e
la paura di perdere ciò cui si è troppo attaccati.
Quante volte parole necessarie non vengono proferite perché trattenute da un qualche pensiero
che fa balenare il pericolo di perdere privilegi
o semplicemente la stima di qualcuno, dei cui
favori si sente di non poter fare a meno! In casi
del genere il silenzio è colpevole, non può essere
attribuito a discrezione, pudore o rispetto, ma
a interesse personale, denotando solo mancanza
di libertà da sé stessi. Solo chi non ha più niente da perdere, o chi è disposto a perdere ciò che
non ritiene irrinunciabile, potrà esperire l’autentica parresia. E non si ha più niente da perdere
quando si è già deposto tutto e si è consapevoli che l’essenziale non potrà essere sottratto da
nessuno.
Si tratta certo di un cammino arduo, che richiede tutta la vita, ma che è possibile. Ricordiamo le parole di Gesù: “Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima” (Mt 10,28). Se Gesù è
stato capace di una vera parresia è perché aveva
già deposto la propria vita e non aveva più nulla da perdere; non per disprezzo di quello che
era, ma perché convinto che l’essenziale è inattaccabile dal vero male, essendo nelle mani del
Padre. Per questo egli può dire: “Nessuno mi
toglie la [vita] ma io la depongo da me stesso”
(Gv 10,18).
Primo presupposto, dunque, della parresia nei
rapporti interpersonali è la libertà da sé che vince la paura, madre della menzogna. Quest’ultima
infatti si nutre sempre di paure: mente chi ha
paura di apparire per quello che è, mentre è libero da sé chi ha il coraggio di riconoscersi e di
apparire senza vergogna e senza finzioni.
Vi è poi un secondo presupposto alla parresia
nelle relazioni interpersonali, che è anche necessario alla parresia con sé stessi appena evocata:
si tratta della fiducia in Dio che, come dicevo, è
un tratto tipicamente neotestamentario. Nel nt
si parla a più riprese dello “stare con parresia”
davanti a Dio, mettersi alla sua presenza con fiducia e senza timore, e pregarlo con fiducia (cf.
1Gv 5,14).
Essa rende innanzitutto possibile la parresia
con sé stessi. Se Dio infatti non accorda la sua
fiducia, non è possibile essere senza paura. Senza il suo sguardo amorevole e il suo perdono non
è possibile non solo guardare a lui, ma neppure a sé stessi. Senza Dio, ogni nostro peccato
è un macigno che schiaccia. Dice in proposito
Giovanni Crisostomo, commentando la Lettera agli Ebrei 10,19-25 e precisamente il passo
in cui l’autore dice: “Fratelli, noi abbiamo la
parresia…”:
Da dove viene la parresia? Dalla remissione.
Come infatti i peccati producono vergogna,
così la loro completa remissione dà luogo alla
parresia (1).
La fiducia in Dio rende poi possibile rivolgersi
all’altro con parresia, come mostra l’esperienza di Gesù, che ha potuto sostenere le contraddizioni provocate dalla sua franchezza perché consapevole della sua unione con il Padre. Ciò gli fu
possibile grazie all’intima persuasione di potersi
affidare a lui anche nei frangenti in cui più grande era la solitudine, come durante la passione.
Per questo egli assaporò l’assoluta desolazione
solo nel momento in cui, nell’ora cruciale della
croce, non avvertì più la presenza del Padre (cf.
Mt 27,46).
La fiducia in Dio, cioè la consapevolezza che
il Signore è presenza affidabile, dà forza nella
prova e rende possibile la parresia nelle relazioni interpersonali non perché autorizza a credere
che Dio sia dalla nostra parte, ma semplicemente perché sa che egli ama e perdona, che egli
è presenza che accoglie. Inoltre, la consapevolezza di stare davanti a Dio con fiducia educa
a una parola detta per il bene e senza malizia,
come anche educa al silenzio quando è richiesto
di tacere.
Allora è possibile sperimentare quanto la
Scrittura dice circa il suo essere dono di Dio
e non conquista umana. Se è possibile esperire una qualche parresia con noi stessi, con gli altri e anche con Dio, ciò è solo perché il Signore
l’ha guadagnata per noi, come dice la Lettera agli
Ebrei. Noi possiamo stare con fiducia davanti
a Dio perché abbiamo un sommo sacerdote che
sa compatire le debolezze e ci rende capaci di
accostarci al trono della grazia con parresia (cf.
Eb 4,15-16). Per questo, dice ancora l’autore
della lettera: “Fratelli, noi abbiamo la parresia
(parrhesían) di entrare nel santuario, per mezzo
del sangue di Gesù” (Eb 10,19).
Di questo ci è fatto dono sino alla fine, fino
al giorno del giudizio, come dice la Prima lettera di Giovanni: “Figlioli, rimanete in lui [il Figlio], perché possiamo avere parresia (parrhesían)
quando egli si manifesterà e non veniamo da lui
svergognati alla sua venuta” (1Gv 2,28). Nella
fiducia nel giorno del giudizio si esprime anche
la perfezione dell’amore: “In questo l’amore ha
raggiunto tra noi la sua perfezione: che abbiamo parresia (parrhesían) nel giorno del giudizio”
(1Gv 4,17).
La parresia nelle relazioni interpersonali è
dunque sostenuta dalle altre due: quella con sé stessi e quella davanti a Dio. Poiché, come si è
visto, solo la libertà da sé stessi e la fiducia in un
Dio che tutto custodisce nelle sue mani, sempre
e ovunque, potrà rendere possibile una parresia
autentica, capace di una parola di verità, vivente e buona.
Note:
1) Giovanni Crisostomo, Omelie sull’Epistola agli ebrei 19,1, a cura
di B. Borghini, Paoline, Alba 1965, p. 288.
AUTORE
Sabino Chialà (Locorotondo 1968) è monaco e priore di Bose dal 2022 a oggi. Studioso di ebraico e siriaco, si è dedicato in particolare allo studio della figura e dell’opera di Isacco di Ninive, di cui ha recentemente pubblicato la prima traduzione italiana completa della prima collezione dei suoi scritti.