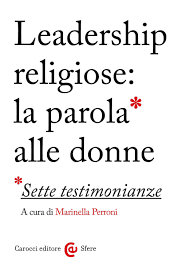A guidare la fede arrivano le donne: la rivoluzione di vescove, rabbine, pastore
|
|
|
|
|
|
|
24 luglio 2023
La emarginazione del femminile, anzi della femminilità, è inequivocabilmente l'unico tratto in
comune di gran parte delle civiltà passate (e non di rado pure presenti) nel mondo. È un fatto
talmente ovvio e scontato da sembrare necessario, inevitabile. Provare a chiedersi il perché di
questa evidenza significa aprire orizzonti di tempo e spazio sconfinati, e dunque enigmatici. Tanto
vale non farsi troppe domande. Il femminile – e la femminilità – sono stati per millenni oggetto di
desiderio e diffidenza: la donna porta con sé la colpa di destare l'istinto (che ce l'avesse anche lei, il
richiamo dell'istinto, ha rappresentato per secoli e millenni un dettaglio trascurabile) e di portare,
cioè di generare la vita. Creatura creatrice, era (è) custode di un mistero che scotta, e lo fa più che
mai per le grandi religioni monoteistiche in cui di Creatore ce n'è uno soltanto, per antonomasia.
Civiltà e confessioni hanno unanimemente segregato il femminile, o quantomeno lo hanno ridotto al
silenzio. Per la tradizione ebraica, ad esempio, la voce femminile è scivoloso strumento di
seduzione: nell'ortodossia più stretta non può udirsi in pubblico, proprio perché «è bella». Ma la
voce del cantore maschio che si leva nella preghiera sinagogale, più bella è, meglio è. Tante
confessioni cristiane vietano tassativamente il sacerdozio femminile, perché «Gesù non ha mai dato
l'ordinazione a una donna». Ma Gesù non ha mai ordinato sacerdote nessuno, uomo o donna che
fosse, dicono le fonti senza ambiguità. E non c'è ricerca spirituale che tenga: che una donna possa
diventare buddha, cioè "illuminata" è questione tutta ancora da vedersi.
Perché come in quasi tutti gli altri campi, anche in quello della fede le donne sono da sempre
oggetto e non soggetto. L'ebraismo stabilisce che l'identità si trasmette per via femminile: è ebreo/a
chi è figlio/a di madre ebrea. E a questo proposito la tradizione ci spiega che non è una faccenda
puramente biologica, anzi, di imprinting educativo: alla donna spetta gettare le fondamenta della
piccola persona che mette al mondo. Eppure l'ebraismo ortodosso nega la professione (ché di questo
e non di una vocazione sacerdotale si tratta) rabbinica alle donne. E persino nell'universo cristiano
protestante la missione pastorale, cui le donne sono ammesse, contempla non di rado una corsa a
ostacoli che al maschile è risparmiata.
Leadership religiose: la parola alle donne, appena pubblicato da Carocci, è in questo senso un libro
più che opportuno, che fa riflettere. Si tratta di una serie di testimonianze molto personali, cui
Marinella Perroni ha dato una coerenza di fondo che le rende una vera e propria disamina sul
presente – nostro, del femminile, della religione oggi. E una delle cose più belle di questo piccolo
libro è il glossario finale: una sorta di panorama globale in cui parole sortite da diversi universi di
fede si ritrovano insieme, una dopo l'altra in un ordine alfabetico che non fa distinzioni di genere,
potere, vissuti.
Marinella Perroni, Miriam Camerini, Letizia Tomassone, Elizabeth E. Green, Teodora Tosatti,
Marisa Iannucci, Carla Gianotti: teologhe, pastore, studiose, maestre. Si raccontano qui, alternando
alla propria esperienza personale dati storici, notizie, riflessioni più o meno amareggiate. Tosatti, ad
esempio, è una vescova vetero-cattolica che ha abbracciato «consapevolmente» il cristianesimo a
diciassette anni e per venti è stata pastora valdese prima di sentire il bisogno di rientrare in seno al
cattolicesimo, ma soprattutto tornare alle origini del testo, cioè alla Bibbia. Camerini sta studiando
in uno dei pochi seminari rabbinici ortodossi che ammette le donne, a Gerusalemme. Iannucci è
cresciuta in Romagna a pane e comunismo, prima di abbracciare l'Islam trent'anni fa. Tutte loro
raccontano e si raccontano. Tutte, seppure ognuna da una prospettiva diversa, hanno lo sguardo su
un vuoto e ascoltano un silenzio: l'assenza del femminile. La storia è un po' come quella della
lettura: tutti i dati statistici ci dicono che il pubblico dei lettori in questo Paese è fatto in larga
maggioranza da donne. Eppure sull'altro versante della pagina scritta, la gran maggioranza di chi
scrive è ancora composta di maschi.
Sono le donne che pregano, frequentano i luoghi di preghiera, studiano. Ma il sacerdozio, la
vocazione, la missione, sono ancora affare da uomini: «Sia pure con esiti differenti, le donne hanno
rappresentato e rappresentano un problema per gli apparati istituzionali sia delle tre grandi religioni
monoteiste sia del buddismo che, lentamente e soprattutto silenziosamente, si sta diffondendo anche
tra gli italiani», scrive Perroni, a sua volta biblista cattolica. E non è soltanto (per quanto
inopportuno sia in questo caso l'avverbio) una questione di accesso al sacerdozio: il silenzio
imposto al femminile negli spazi della fede è qualcosa che riguarda tutto, e più che mai in un
presente in cui il bipolarismo fra clero e laicato è sempre più labile, più vuoto di senso, tanto nelle
religioni a struttura piramidale quanto in quelle teoricamente più "orizzontali". Tutto è più fluido
oggi, anche in questo mondo. Lo spazio della fede è sempre più variegato, sempre più propenso a
riconoscere e rispettare – se non ad accogliere – le differenze: una società multicolore è anche
necessariamente una società multiconfessionale. Ma non c'è dialogo interreligioso che tenga, se
prima non si stabilisce un'agenda comune sul tema del femminile. Su come poter cambiare uno
status quo atavico senza sovvertire tutto il resto, perché come dice il Talmud «non c'è tradizione
senza novità».
Perché di questo si tratta: per dare voce e parola alle donne nell'universo religioso, qualunque esso
sia, bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo lo si potrà inventare solo
andando alle origini, a quelle fonti sulle quali (e non di rado malgrado le quali) si è costruita
l'emarginazione. A partire dalla colpa di Eva, per la quale basta leggere parola per parola, riga su
riga, il racconto delle origini per vedere sovvertito quel che credevamo di sapere: infatti nella
Genesi quella colpa è un merito di consapevolezza, quella maledizione altro non è se non il dono
della storia che Dio fa all'uomo e alla donna. E invece, come scrive Perroni, «All'esaltazione della
donna in nome del riscatto che Maria ha pagato per il peccato di Eva non corrisponde però l'ascolto
delle donne reali, delle loro fatiche e delle loro aspettative; all'idealizzazione della donna e alla
magnificazione delle sue virtù corrisponde invece la sua esclusione da ogni riconoscimento
ministeriale», e non solo.
Cambiare si può e si deve. Senza paura del passato ma neanche del presente. Sapendo che solo
rinnovandosi si va incontro al futuro, e che la tradizione è un ricevere e un dare e mai un ripetersi
sempre uguale a se stesso.