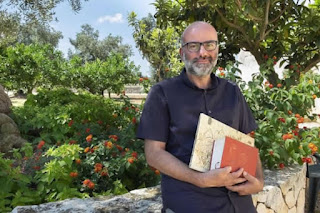Bose. Per comunicare il fascino del Vangelo - intervista a Sabino Chialà
|
|
|
|
|
|
|
Intervista al priore del monastero di Bose, fr. Sabino Chialà,
curata da Daniele Rocchetti
Arrivo a Bose una mattina molto presto. Lo scenario, splendido, della Serra fa da sfondo al grappolo di edifici e alla chiesa inaugurata nel 1999. In lontananza, il profilo dell’elegante campanile della chiesa romanica di san Secondo che risale alla prima metà dell’XI secolo.
Sono salito per incontrare Sabino Chialà, priore della Comunità dal 2022. Sono passati cinque anni dal Decreto singolare – approvato in forma specifica da papa Francesco – dove si definivano “con chiarezza orientamenti e modalità” per risolvere una vicenda che ha turbato molti. I più, ignari di cosa sia effettivamente accaduto, anche per il necessario silenzio assunto per tutelare le persone coinvolte. Uno tsunami che ha portato all’allontanamento del fondatore, Enzo Bianchi e di alcuni fratelli e sorelle.
Prima di ritirarci, incrocio fratelli e sorelle che conosco da molti anni e scambio con loro un po’ di parole. Tutti raccontano di una comunità finalmente ripartita, che – senza dimenticare quanto è accaduto – ha lasciato alle spalle il tempo della fatica, l’umiliazione della divisione. Sono ripartiti i convegni internazionali sulle spiritualità d’Oriente e di Occidente, così pure i confronti e gli incontri. Molti preti partecipano alle settimane di Esercizi e in tanti chiedono di poter essere accolti alle settimane bibliche e di spiritualità. Soprattutto, una vita comune all’insegna di una fraternità che è stata saggiata dalla prova ma che resiste. Un ricominciamento che dà futuro e speranza.
Cosa ha voluto dire per la comunità attraversare il tempo della prova?
E’ stata un’esperienza di contraddizione e di sofferenza. Di umiliazione, anche, perché abbiamo sentito il peso e la responsabilità di non essere riusciti a fare meglio. Sofferenza, non solo per ciò che abbiamo vissuto in comunità ma anche per quello che abbiamo causato in tanti che ci hanno voluto bene, che soffrivano e non capivano quello che stava accadendo tra di noi. Allo stesso tempo, è stata l’occasione per rimisurare le motivazioni di quello che ci ha chiamato qui e di ciò che cerchiamo di vivere: l’occasione per saggiare il fondamento dell’edificio. Come sempre nei momenti di crisi vai più a fondo, vai all’essenziale. E accanto alla sofferenza c’è stata, forse, anche un po’ di purificazione.
Il ridimensionamento della comunità ha creato scompensi?
Il problema, come spesso abbiamo modo di sperimentare, non ha a che fare solo con i numeri. Certo, il fatto di essere in meno ci ha obbligati ad affrontare un’istanza urgente di riconfigurazione con la quale da tempo ci confrontavamo, diciamo con scarsi risultati. La questione fondamentale resta però quella delle relazioni, perché nelle realtà autentiche si instaurano profondi rapporti personali. Quando manca una persona manca un mondo, una storia. La nostra vicenda ci ha portato a ricomprendere meglio tutto questo: a sospendere alcuni rapporti, a risignificarne altri, ad aprire con persone che avevano lasciato ben prima della crisi. Un processo in divenire e che resta aperto.
Se ti chiedessi di rintracciare uno “specifico” di Bose dove lo troveresti?
Lo specifico di Bose è riconoscibile nella vita concreta di questi fratelli e di queste sorelle, insieme a tutti quelli che hanno condiviso una parte del cammino, piccolo o grande, la cui presenza resta. Bose si radica nella tradizione monastica, nella quale cerca di vivere in ascolto del Vangelo. La vita monastica, poi, si articola intorno a due binomi: preghiera e lavoro da una parte; vita comune e solitudine dall’altra. Si tratta di una vita condivisa nella diversità e insieme l’esperienza di una parzialità e di un’attesa che il celibato vorrebbe raccontare.
La vita nella diversità, nella nostra vicenda, in obbedienza a quanto la storia suggeriva, ha assunto i tratti dell’ecumenismo e della vita mista, di uomini e donne insieme. L’altro tratto, quello della parzialità, significa, invece, una relazione che è piena nella misura in cui è anche rispettosa, che sa custodire anche una distanza. La vita monastica, in fondo, ha sempre cercato di indicare un oltre. Stare profondamente dentro le cose, vivere intensamente il rapporto con gli altri, con i beni, con l’ambiente, con la storia in cui ci si trova, ma al tempo stesso essere segno di ulteriorità, dell’attesa del Signore che viene.
Qual è il senso dell’esperienza monastica?
Ricordo sempre con vividezza un incontro che feci quando ero da poco arrivato a Bose. Alla nostra tavola era presente un viandante. Chi presiedeva la tavola, al termine del pranzo, gli chiese da dove venisse e perché fosse venuto da noi. Rispose che veniva dalla Serbia e di fronte all’insistenza sul “perché era venuto”, ci disse: “Sono anni che frequento monasteri perché non capisco a cosa servite e continuerò a frequentarli per cercare di capire”.
Quell’espressione mi balenò come fosse una risposta ad una domanda che proprio nei miei primi giorni qui a Bose continuavo a ruminare dentro di me: “in fondo, qual è il senso ultimo di questa – anche della mia – vocazione?”. Oggi credo che il senso ultimo sia quello di abitare quella domanda e di tenerla aperta, nutrendola di ascolto della Parola, nella preghiera. Forse la vita monastica, per la Chiesa e per il mondo, ha ancora questa funzione: essere luogo di accoglienza e alimentare domande.
Quali sono secondo te le sfide che questo tempo pone con più forza rispetto a ieri alla vita monastica, al monachesimo, oggi?
Credo che ci interpelli proprio in quello in cui spesso siamo più fragili, cioè la capacità di vivere insieme nella diversità. Se dicessi che il monachesimo è il luogo in cui si vive questa dimensione sarei presuntuoso. Perché – e lo abbiamo visto in modo evidente qui tra noi – nelle nostre realizzazioni siamo spesso deficitari, mostriamo tutte le nostre contraddizioni. Eppure credo che lì ci sia qualcosa di importante da vivere e da trasmettere. Cioè questa sorta di convivialità delle differenze, di parola e di incoraggiamento a non arrendersi sulla via della composizione delle diversità, alla ricerca di quell’elemento comune che ci consente di sostenere questa grande sfida. Non arrendersi… continuare a riprovarci.
Qualche mese fa Massimo Cacciari in un’intervista sosteneva che il problema non è la secolarizzazione che, anzi, inizia con il cristianesimo stesso. La tragedia, a suo dire, è la scristianizzazione. Una frattura della memoria che ci rende incapaci di raccontare la “differenza cristiana”. Come rendere la vicenda di Gesù di Nazareth plausibile all’uomo contemporaneo?
Narrandola come un’umanità che racconta Dio. Un grande Padre della Chiesa siriaca diceva che è dalla qualità umana di Gesù che noi capiamo che era figlio di Dio. Un’umanità talmente piena ed eloquente che chi lo vedeva diceva “questo è Dio”. Ecco, credo che sia qui la grande sfida dei cristiani di oggi: essere capaci in prima persona di vivere questa relazione con Gesù e di farne parte, di trasmetterla a persone che spesso non hanno accesso neppure alle nozioni più elementari per capire di che cosa si sta parlando.
Per fare un esempio, racconto un fatto di qualche mese fa: un giovane americano laureato in astrofisica, dopo aver lavorato per qualche anno alla NASA, lascia tutto per fare un viaggio in Italia. Capita in un monastero buddista in Toscana, lì incontra un ragazzo che ci frequenta che gli dice “Voglio farti conoscere un monastero cristiano”. Lo porta nella nostra fraternità di Assisi, lui rimane incantato e resta lì un mese. Sale poi qui a Bose, sta con noi un altro mese scoprendo un mondo – quello di Gesù Cristo e del Vangelo – di cui non aveva minimamente cognizione. Era interessante e commovente vedere l’impatto che aveva su di lui proprio la figura e il messaggio di Gesù.
Ciò che mi ha dato da pensare è che per fare il legame tra la sua ricerca e la nostra realtà c’è voluto un monastero buddista e un ragazzo incontrato lì per caso. Ecco, una realtà del genere 50 anni fa ci sarebbe sembrata fantascienza. Oggi è all’ordine del giorno. Di questi esempi potrei raccontarne diversi.
Ricordo quando ero nella fraternità di Ostuni un giovane tedesco di 23 anni. Arriva il Giovedì Santo, mentre percorre la via Francigena del Sud, e chiede ospitalità. Noi eravamo pienissimi ma riusciamo a trovargli un posto. Viene alla liturgia della sera e alla fine dice: “Che cos’è che sta accadendo?”. Gli rispondo: “Sai, noi cristiani oggi ricordiamo la cena ultima di Gesù con i suoi amici”. “Ma che bello! Potrei rimanere?”. Ha vissuto con noi tutto il triduo, fino alla notte pasquale. Il giorno dopo, entusiasta di questa realtà di cui anche lui non aveva la minima cognizione, è ripartito. È una realtà nuova.