Vito Mancuso “San Francesco, complesso e radicale. Ecco perché ha senso prenderlo a modello”
|
|
|
|
|
|
|
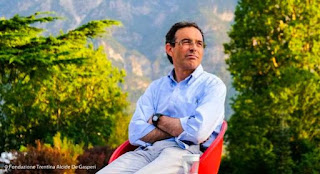
Dal 2026 il 4 ottobre tornerà festa nazionale per ricordare un uomo che nutre il nostro immaginario collettivo da secoli.
Che cosa in realtà festeggeremo il 4 ottobre di ogni anno celebrando a partire dall'anno prossimo la
memoria di san Francesco d'Assisi trasformata in festa nazionale? La figura di questo popolarissimo
santo, infatti, è ben lungi dall'avere la medesima interpretazione.
Da un lato fu il primo nella storia a
ricevere le stigmate e come tale è il simbolo del dolore di Cristo; dall'altro venne soprannominato
"il giullare di Dio" già dai suoi contemporanei e come tale è diventato il simbolo altrettanto efficace
della gioia spirituale che rasenta la pazzia.
Da un lato fu un ribelle intransigente alle regole
dell'economia, della politica e del potere alla base di questo mondo; dall'altro fu estremamente
obbediente alla Chiesa e ai suoi ministri insegnando ai frati ad applicare scrupolosamente la
medesima sottomissione.
Da un lato superò l'antropocentrismo per il suo amore verso la natura e le
prediche agli uccelli; dall'altro nella sua laude detta Cantico delle creature o di Frate Sole non
nomina neppure un animale.
Da un lato dimostra una cultura elementare e un uso del latino spesso
imperfetto; dall'altro compone una delle poesie più belle e più amate della letteratura italiana.
Da un
lato disprezza i libri e lo studio mettendo in guardia i suoi frati dal dedicarvisi; dall'altro è all'origine
di un ordine religioso da cui presto nasceranno alcuni tra i più acuti teologi e filosofi del tempo
quali Alessandro di Hales, Ruggero Bacone, Roberto Grossatesta, Bonaventura, Duns Scoto, e
Guglielmo di Occam dalla logica implacabile tramite il suo cosiddetto "rasoio".
Da un lato si recò
amichevolmente dal sultano d'Egitto dando vita a uno dei primi episodi del dialogo interreligioso,
tant'è che Assisi è diventata la patria dell'ecumenismo e del pacifismo; dall'altro il suo ordine fu tra i
più zelanti nel perseguitare gli eretici rivaleggiando con l'ordine dei domenicani nel sostenere la
Santa Inquisizione, tant'è che Dostoevskij vestì il suo Grande Inquisitore non con l'abito
cardinalizio ma con un saio.
Da un lato il governo fascista ne promosse la memoria e D'Annunzio lo
proclamò «il più italiano dei santi e il più santo degli italiani»; dall'altro la sinistra vede in lui il
padre dell'ecologia e della lotta contro le ingiustizie, con la teologia della liberazione sudamericana
che l'ha assunto quale modello e con papa Bergoglio che decise di chiamarsi proprio come lui. Chi
fu quindi veramente Francesco d'Assisi, figlio di Pietro di Bernardone, un mercante che aveva
scelto di chiamarlo così (e non Giovanni come voleva la moglie) per onorare i suoi affari con la
Francia?
Come per altri grandi personaggi del passato a partire da Gesù, la domanda sulla vera identità di san
Francesco, e di conseguenza sul vero oggetto della festa nazionale, è destinata a rimanere senza una
risposta definitiva. Il motivo è la situazione delle fonti francescane, cioè di quella ventina di opere
sulle vicende biografiche di Francesco composte nei decenni successivi alla sua morte le quali
presentano palesi difformità e vere e proprie contraddizioni. Lo mise in luce per primo lo storico
francese Paul Sabatier con la sua Vita di San Francesco del 1894, dando origine alla cosiddetta
"questione francescana" e subendo il subitaneo inserimento nel famigerato Indice dei libri proibiti
della Chiesa cattolica. Ma i problemi non si risolvono con la censura e la violenza, e infatti a
distanza di oltre un secolo la questione sollevata da Sabatier rimane del tutto intatta. Non a caso
Alessandro Barbero nel suo recente libro su san Francesco pubblicato da Laterza ha scelto di non
presentare "la" biografia del santo, ma di analizzare sette diverse versioni della sua vita, affermando
all'inizio: «Certamente non mi illudo di essermi avvicinato più di altri a stanare il "vero"
Francesco»; e concludendo alla fine: «L'enorme sforzo profuso dall'Ordine francescano per
conservare la memoria di Francesco ha finito per creare non tanto il ricordo di un uomo veramente
esistito, quanto un personaggio dell'immaginario collettivo».
In questa società che vive sempre più di immagini individuali prodotte artificialmente dalla
potentissima industria dell'intrattenimento, l'immaginario collettivo è molto importante e va nutrito,
se non vogliamo perdere del tutto il fatto di essere una collettività, una società, forse addirittura una
civiltà. E che tale immaginario collettivo venga nutrito tramite la figura di Francesco d'Assisi è una
scelta, a mio avviso, assai felice, perché in questo mondo dove tutto sembra sottoposto alla logica
del denaro e del potere, la figura di questo santo testimonia da otto secoli che l'esistenza umana si
compie davvero quando vive onestamente in funzione di qualcosa di più grande di sé e di più
grande del potere.
Il punto di svolta nella sua vita fu l'incontro con la povertà più sconvolgente, quella dei lebbrosi. In
un imprecisato giorno d'autunno del 1205 Francesco, allora ventiquattrenne, vide un lebbroso, scese
da cavallo e lo baciò. Il risultato fu un radicale cambiamento interiore, descritto così nel suo
Testamento del 1226: «E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo». Dicendo «uscire dal mondo»
Francesco intendeva l'ingresso nella vita religiosa, ma, come ha scritto padre Balducci, egli «in
realtà entrò nel mondo proprio nel momento che ne uscì». È nell'incontro con il dolore, infatti, che
si attua la più profonda e più autentica comunione con la realtà che chiamiamo mondo. Prendersi
cura del dolore e delle sue vittime produce quell'inaspettato cambiamento dell'intenzione del cuore e
dello sguardo sul mondo che porta a riconoscere ciò che veramente conta nella vita e ad
abbandonare le futilità. Ma c'è un incredibile paradosso: che la presa in carico del dolore produce in
chi la compie l'opposto, cioè il sorgere della gioia. Per questo Francesco prescrisse nella Regola non
bollata del 1221: «E si guardino i frati dal mostrarsi tristi all'esterno e oscuri in faccia come gli
ipocriti, ma si mostrino lieti nel Signore e giocondi e garbatamente allegri». Penso sia precisamente
questa stretta connessione tra dolore e vera gioia la prospettiva da cui emerge la preziosità di san
Francesco e della sua festa per chiunque abbia ancora fiducia nell'umanità e nella sua capacità di
bene.
Vito Mancuso, La Stampa 3 ottobre 2025





