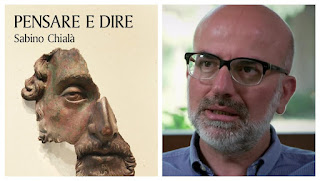Sabino Chialà "La parresia vissuta da Gesù"
|
|
|
|
|
|
|
La ricorrenza evangelica più antica del sostantivo “parresia” è riferita a Gesù e si trova al
cuore del Vangelo secondo Marco, il più antico dei quattro. Subito dopo la professione di
fede di Pietro, che segna il centro del secondo
vangelo, Gesù annuncia per la prima volta la
sua passione, morte e resurrezione. Marco dunque annota: “Faceva questo discorso con parresia” (Mc 8,32).
Credo sia significativo che la prima espressione di parresia vissuta da Gesù, di cui ci parlano i vangeli, riguardi proprio il suo destino:
Gesù comincia a parlare e dunque a entrare nel
cammino doloroso che gli si pone dinanzi. Annuncia agli altri, ma allo stesso tempo percorre
il proprio cammino, che accetta senza sottrarsi.
La confessione messianica di Pietro gli fa intravedere la fine, ed egli l’affronta responsabilmente
e coraggiosamente.
Tale prima forma di parresia, quella su di sé,
è alla radice dell’altra, mostrata da Gesù nella
sua predicazione e nella sua azione. Innanzitutto
quando parla, come gli riconoscono i suoi stessi interlocutori, ad esempio farisei ed erodiani
che gli pongono il quesito sul tributo a Cesare:
“Maestro, sappiamo che sei veritiero e
insegni la via di Dio secondo verità.
Tu non hai soggezione di alcuno, per
ché non guardi in faccia a nessuno” (Mt 22,16).
Da notare
l’insistenza sulla veridicità di Gesù, come riflesso dalla sua imparzialità, cioè dalla sua libertà:
si insiste nel dire appunto che il suo parlare è
vero perché libero, una qualità, quest’ultima,
che i suoi uditori gli riconoscono anche altrove
(cf. Gv 7,26). Più di una volta nel quarto vangelo Gesù afferma di parlare con parresia (cf. Gv
11,14; 16,25; 18,20).
Egli mostra tale libertà perché non si lascia
condizionare da nessuno, non segue neppure una
strategia propria, una supposta convenienza, a differenza dei capi che anche in questo mostrano
la loro distanza dal rabbi di Galilea. Mi riferisco
al caso già evocato trattando della coscienza (cf.
Mt 21,23-27). L’atteggiamento di quegli interlocutori di Gesù mette in luce un primo aspetto
di ciò che si oppone alla parresia: il calcolo utilitaristico. Le risposte date non ricercano la verità
“possibile”, ma sono dettate dalla convenienza
o dalla paura delle reazioni, in questo caso delle
folle: hanno paura di perdere il consenso. Gesù
invece mostra la sua parresia, che qui si esprime
in un silenzio carico di significato: “Neanch’io
vi dico con quale autorità faccio queste cose”
(Mt 21,27).
In talune circostanze, infatti, il silenzio è l’unica verità possibile ed è anch’esso espressione di
parresia. Nel quarto vangelo, dove pure a Gesù
è spesso riconosciuta la libertà nel parlare, si ricorda il suo ritirarsi dinanzi alla decisione dei
capi di metterlo a morte: “Gesù dunque non
camminava più con parresia tra i Giudei, ma di lì si ritirò nella regione
vicina al deserto, in una città chiamata Efraim”
(Gv 11,54). Qui l’espressione “non camminava più con parresia” indica il fatto che Gesù non
si mostrava più in pubblico, ma è significativo
il lessico impiegato. Altre volte la parresia del
Maestro si fa parola sferzante, come nella lunga
requisitoria contro l’ipocrisia di scribi e farisei
(cf. Mt 23,1-32), dove le sue parole assumono
coloriture profetiche.
Gesù parla con parresia e invita i suoi discepoli a fare altrettanto, ad esempio laddove invita a
non temere di rischiare una parola che potrebbe
provocare ripercussioni:
Non abbiate paura di loro, poiché nulla vi è
di nascosto che non sarà svelato, né di segreto
che non sarà conosciuto … Non abbiate paura
di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno
potere di uccidere l’anima … Due passeri non
si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del
Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura:
voi valete più di molti passeri (Mt 10,26-31).
È possibile parlare e agire con parresia, anche
laddove si profilano violenze e persecuzioni, se vi è la consapevolezza che tutto avviene alla presenza di Dio e che nulla va perduto poiché nulla
sfugge alle sue mani amorevoli.
Oltre alle parole, denotano parresia anche le
azioni di Gesù, come attestato in molti passi
evangelici. Egli mostra di essere libero con quel
le medesime categorie di persone che abbiamo
visto agire con lui con parresia, primi fra tutti
i peccatori. Si mostra libero di agire, incurante
dei giudizi altrui, quando chiama Matteo e poi
si siede alla sua tavola insieme ai suoi discepoli
e a pubblicani e peccatori (cf. Mt 9,9-13), scandalizzando i farisei; quando guarisce in giorno
di sabato un uomo dalla mano paralizzata, contestando un’interpretazione rigida e dunque falsa
della Legge (cf. Mt 12,9-14); o quando scaccia i
venditori dal tempio (cf. Mt 21,12-17).
Infine Gesù mostra parresia nei confronti del
Padre, nei vari momenti di preghiera solitaria
di cui parlano i vangeli, soprattutto Luca. Una
preghiera in cui osa rivolgersi a Dio chiamandolo “Padre” (cf. Mt 6,9); in cui mette davanti
a lui la propria angoscia, come nel Getsemani,
chiedendogli che quel calice fosse allontanato da lui, anche se alla fine si affida alle sue mani (cf. Mt 26,39); in cui, nel momento estremo
dell’agonia sulla croce, grida la sua desolazione
dinanzi a un Padre che sente assente, mettendo
tutto nelle parole di una preghiera, il salmo 22
(cf. Mt 27,46). Anche la preghiera che Gesù lascia ai discepoli, accogliendone la richiesta, è un
invito alla parresia con il Padre (cf. Mt 6,9-13;
Lc 11,1-4).
Quella vissuta da Gesù è dunque una parresia
multiforme, che appare come accettazione della
propria missione (parresia con sé stesso), come
relazione intima con il Padre (parresia dinanzi
a Dio), come parole e gesti che non temono di
provocare e di scandalizzare (parresia nelle relazioni interpersonali).
AUTORE
Sabino Chialà (Locorotondo 1968) è monaco e priore di Bose dal 2022 a oggi. Studioso di ebraico e siriaco, si è dedicato in particolare allo studio della figura e dell’opera di Isacco di Ninive, di cui ha recentemente pubblicato la prima traduzione italiana completa della prima collezione dei suoi scritti.