Vito Mancuso “Verso il Conclave”
|
|
|
|
|
|
|
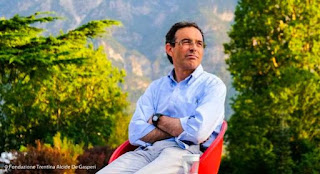
La storia del papato e della Chiesa nella seconda metà del Novecento e in questi due decenni del nuovo secolo si può schematicamente descrivere mediante il terzo principio della dinamica di Newton: “A ogni azione corrisponde una reazione pari e contraria”.
L’azione che mise in moto la dinamica della Chiesa contemporanea fu quella di papa Giovanni XXIII che, nel nome di una strategia complessiva da lui denominata “aggiornamento” (“dibattutissimo termine”, lo qualificò il grande storico della Chiesa Hubert Jedin), convocò il Concilio ecumenico Vaticano II, celebrato tra il 1962 e il 1965. Lo scopo di papa Giovanni era esplicito: che la dottrina “sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo” (dal discorso di apertura del concilio, 11 ottobre ’62). L’aggiornamento voluto dal Papa bergamasco effettivamente ci fu …Gli ebrei passarono da “perfidi giudei” a “fratelli maggiori”, gli ortodossi e i protestanti da “eretici e scismatici” a “fratelli separati”, le altre religioni da insieme di “infedeli” a “raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini”. La libertà di coscienza in materia religiosa, prima bollata come “assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio” (Gregorio XVI, Mirari vos, 1832), divenne oggetto della Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae del 7 dicembre 1965, il documento più sofferto dei lavori conciliari. Altre svolte significative riguardarono la Bibbia, la liturgia e in genere il rapporto con il mondo, passato dalla condanna di tutto ciò che di nuovo esso produce a un atteggiamento di attenzione e di benevolenza. Pio IX descriveva il processo storico come “scellerate trame degli empi, che, come flutti di mare tempestoso, spumano le proprie turpitudini”, il Vaticano II insegnò a “scrutare i segni dei tempi per conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo” perché “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi” sono le stesse dei discepoli di Cristo e “nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”. Ma a questa potente azione non poteva non seguire, come insegna la dinamica di Newton, una altrettanto potente reazione.
Il Vaticano II non poté essere concluso da Giovanni XXIII che morì proprio nel mezzo dei lavori conciliari, venne portato a termine da Paolo VI, il Papa che cominciò a depotenziarne la carica innovativa. Il luogo in cui questo depotenziamento appare con più evidenza è la morale sessuale. Così il cardinal Martini nelle sue Conversazioni notturne a Gerusalemme riferendosi a Paolo VI: “Sottrasse scientemente l’argomento ai dibattiti dei padri conciliari; in questa materia volle assumere una responsabilità altamente personale”. Paolo VI avocò a sé la materia sessuale impedendo al concilio di esprimersi al riguardo per timore di una frattura troppo forte rispetto al passato. A suo avviso la Chiesa poteva sopportare il rinnovamento nel rapporto con le altre religioni, nella liturgia, nella libertà religiosa, non però in materia sessuale, dove l’innovazione rispetto alla Casti connubii di Pio XI che aveva condannato ogni tipo di contraccezione avrebbe provocato una frattura così ampia da prefigurare uno scisma. Così, temendo la divisione, Paolo VI impedì al concilio di esprimersi sulla morale sessuale diminuendone la spinta rinnovatrice e pubblicò nel 1968 una sua enciclica il cui esito è descritto così da Martini: “L’enciclica Humanae vitae ha purtroppo prodotto anche un effetto negativo. Molte persone si sono allontanate dalla Chiesa e la Chiesa dalle persone. Ne è derivato un grave danno”.
Giovanni Paolo I ebbe solo il tempo di un luminoso sorriso e di ricordare la tenerezza materna di Dio, mentre il lungo pontificato di Giovanni Paolo II disegna una parabola complessivamente all’insegna della conservazione e a tratti della restaurazione. In verità nel suo papato non mancarono gesti innovativi e profetici, perfettamente nella linea conciliare, come la richiesta di perdono per le colpe storiche della Chiesa (a partire dall’abiura inflitta a Galileo nel 1633) e come la bellissima preghiera comune con i rappresentanti delle altre religioni ripetuta due volte ad Assisi nel 1986 e nel 2002, e la visita alla sinagoga di Roma nel 1986. Ma nel complesso il suo papato è stato di stampo conservatore per quanto attiene alla conduzione generale della Chiesa a livello di nomine ecclesiastiche, morale sessuale, bioetica e in genere le questioni dottrinali più importanti, non ultimo il ruolo della donna. Tale impostazione dottrinale ebbe nel cardinale Ratzinger quale Prefetto della Congregazione della fede il principale interprete e fu quindi del tutto naturale il passaggio da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI. Il papa tedesco continuò l’operazione di retromarcia, arrivando persino a favorire la Messa in latino e a riabilitare i lefebvriani, i veri e propri oppositori strutturali alla dinamica conciliare. Il vero gesto innovativo di Benedetto XVI furono le sue dimissioni, causate dalla presa di coscienza di non essere in grado di ricoprire il ruolo di Pontefice, anche se egli non smise la veste bianca e non lasciò Roma, come invece, a mio avviso, avrebbe dovuto fare. In vista delle dimissioni egli aveva preparato il suo candidato alla successione, ma i cardinali in conclave preferirono Jorge Mario Bergoglio, che, scegliendo di chiamarsi Francesco e presentandosi come vescovo di Roma, fece subito capire il suo desiderio di riprendere la spinta innovatrice del Vaticano II. Emblematica al riguardo è l’importanza che nel suo pontificato assunse la teologia della liberazione: quei teologi e quegli uomini di chiesa che durante i pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI erano stati emarginati e talora condannati vennero ampiamente riabilitati, come Leonardo Boff che fu uno dei principali estensori dell’enciclica “Laudato si” sull’ecologia del 2015. Ancora più emblematica è la vicenda di Oscar Romero, il vescovo martire di San Salvador assassinato nel 1980 dagli squadroni della morte al soldo delle multinazionali e della giunta militare, che non venne beatificato da Giovanni Paolo II (che pure arrivò a un numero di beatificazioni più alto di quello di tutti gli altri papi messi insieme, ma che riservò a Romero un trattamento gelido durante la sua visita a Roma) né da Benedetto XVI, e che invece venne subito beatificato (2015) e canonizzato (2108) da papa Francesco.
Occorre però sottolineare che purtroppo la spinta innovatrice di papa Francesco non ha avuto la necessaria forza dottrinale e l’ancora più necessaria abilità diplomatica che avevano contraddistinto l’aggiornamento introdotto da papa Giovanni, dotato di ben altra consapevolezza storica e capacità di governo rispetto al papa argentino. Papa Francesco ha voluto sì continuare il rinnovamento, ma per una serie di motivi (tra cui alcuni tratti caratteriali) è risultato incapace di creare quell’armonia necessaria perché il rinnovamento potesse effettivamente procedere. Senza considerare alcune conclamate ambiguità, come l’appellativo di “sicari” riservato ai medici abortisti e poi la visita a Emma Bonino, o in ordine all’omosessualità il “chi sono io per giudicare?” e poi l’uso del termine frociaggine. Così il suo pontificato non è riuscito a tradurre in nessun atto concreto a livello legislativo il desiderio e talora l’impeto del rinnovamento.
Il risultato è quello davanti ai nostri occhi: una Chiesa cattolica divisa, “sfrangiata” la descrive il cardinal Ravasi (Corriere della Sera del 23 aprile scorso), nella quale i progressisti sono scontenti perché le riforme non sono arrivate e i conservatori sono scontenti per il fatto che di queste riforme si parli.
Mi viene in mente il celebre passo dei “Promessi sposi” in cui il Gran Cancelliere spagnolo alle prese con la folla inferocita si rivolge al cocchiere: “Adelante, Pedro, con juicio”. Penso che la Chiesa abbia bisogno di un Papa che la conduca “adelante” e non indietro, ma che lo faccia con più “juicio” rispetto a papa Francesco: meno protagonismo e più collegialità, meno picconate alla curia e più incoraggiamento, meno proclami e più nomine ponderate, meno volontà di stupire e più rispetto della tradizione (è inammissibile, per esempio, che diocesi come Parigi, Berlino, Vienna, Bruxelles, Lisbona e tra le italiane Milano e Venezia, non siano rappresentate al conclave perché Francesco non ha nominato cardinali i rispettivi arcivescovi). Si tratta però, tutto sommato, di questioni secondarie. La vera questione è la direzione complessiva, se “adelante” o se indietro. Tornando a Newton, egli spiegava: “Se qualcuno spinge una pietra col dito, anche il suo dito viene spinto dalla pietra”. Noi presto vedremo quale sarà la spinta che vincerà il conclave: se l’azione del dito o la reazione della pietra.
Vito Mancuso, La Stampa 28 Aprile 2025





