Vito Mancuso “Nel nome del padre”
|
|
|
|
|
|
|
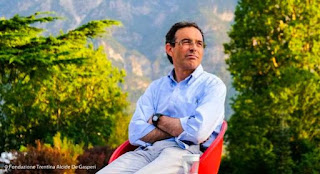
La figura storica di Gesù, e quella religiosa di Cristo vanno esaminate separatamente ma costituiscono due dimensioni comunicanti che si ritrovano in ognuno di noi.
Gesù nacque a Nazaret; Cristo a Betlemme. Gesù aveva un padre terreno; Cristo era il Figlio unigenito del Padre celeste. Gesù aveva quattro fratelli e un numero imprecisato di sorelle; Cristo era figlio unico. Gesù ebbe come maestro Giovanni il Battista; Cristo era cugino del Battista e non aveva bisogno di nessun maestro. Gesù non si capisce senza il Battista; Cristo non si capisce senza Pietro e senza Paolo …
Nessuno di noi ha incontrato Gesù; tutti noi abbiamo incontrato Cristo. Gesù è sconosciuto; Cristo è conosciutissimo. Di Gesù ben pochi parlano e coltivano la spiritualità; di Cristo ogni giorno sulla terra si proclama la natura divina affermando che è «della stessa sostanza del Padre» e si celebra il memoriale della morte e risurrezione, dichiarando di attenderne la venuta: «Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta» (anche se di fatto, ormai, pressoché nessuno attende tale sua venuta).
Alla luce di queste affermazioni, che nel corso del libro verranno tutte documentate, deriva quanto segue: che Gesù e Cristo sono due personaggi diversi. Il che si contrappone alla comune interpretazione bimillenaria che fa di loro una cosa sola, tanto che i più intendono Gesù Cristo come nome e cognome. Ma Gesù e Cristo sono due personaggi diversi. E in quanto tali, rimandano a due religioni altrettanto diverse. La prima tramontò ben presto rimanendo pressoché sconosciuta; la seconda ebbe un successo mondiale divenendo la più diffusa del pianeta. La prima è il gesuanesimo, la religione di Gesù. La seconda è il cristianesimo, la religione fondata successivamente dai suoi discepoli, tra i quali emergono Pietro di Betsàida e Paolo di Tarso.
Gesù è un nome ebreo; Cristo è un nome greco. Ma non è solo una questione di nomi. I nomi sono così importanti proprio perché non è quasi mai solo questione di nomi, in quanto essi portano sempre con sé già nella loro esteriorità il sapore e il valore del contenuto. Gesù-Cristo è l’unione teoreticamente impossibile, e tuttavia da duemila anni storicamente esistente, di una spiritualità ebraica e di una spiritualità greca. Questa unione innaturale costituì la religione in cui l’Occidente per molti secoli credette e su cui fondò la propria civiltà. Atene e Gerusalemme ne costituirono l’anima, Roma il corpo.
Oggi non è più così. Oggi la maggior parte degli occidentali si dice del tutto serenamente non-cristiana. Oggi in questo Occidente (di cui non pochi abitanti neppure sono disposti ad ammettere un’identità culturale comune, tale da plasmare, non dico una civiltà, ma almeno una base per l’etica e la convivenza sociale), il progressivo declino del cristianesimo è un dato di fatto sotto gli occhi di tutti e un processo, a mio avviso, inarrestabile. Gli occidentali avranno sempre meno a che fare con il cristianesimo, di cui non conoscono la dottrina e la storia, non frequentano i riti, non ne leggono il libro sacro, non accettano i valori, ignorano le preghiere. Dal punto di vista religioso qui in Occidente siamo di fatto in una situazione descrivibile come «post-cristiana».
La volontà di illustrare questa condizione e di concorrere in parte a risanarla è la causa che mi ha portato a scrivere questo libro, nella speranza che esso possa contribuire a quella che Teilhard de Chardin chiamava «Religione a misura della nuova Terra» di cui il nostro tempo ha urgente bisogno, anche se non lo sa. Rispetto a essa il teologo e scienziato gesuita scriveva: «Continuo a credere che sia il Cristianesimo – purché opportunamente pensato e ripensato – a contenerla in nuce». Io aggiungo che tale ripensamento non può che essere radicale, ed è in questa prospettiva che ho scritto questo libro.
Lo scopo perseguito da questo libro è duplice: storico e teologico. A livello storico esso consiste nel liberare Gesù da tutte le indebite sovrapposizioni subite dalla sua figura, riportandone alla luce, per quanto possibile, la forma genuina.
A livello teologico lo scopo consiste invece nel mostrare che le sovrapposizioni operate lungo la storia creando il personaggio Cristo, per quanto storicamente indebite e talora anche spiritualmente dannose, avevano una loro necessità e costituirono nonostante tutto un passo in avanti. Il punto, infatti, è che Gesù e Cristo, la Storia e l’Idea, non si escludono a vicenda, non sono tra loro per nulla incompatibili; anzi, dato che rappresentano due dimensioni costitutive di ognuno di noi, Gesù e Cristo hanno in realtà bisogno l’uno dell’altro, così come ognuno di noi ha bisogno sia della Storia sia dell’Idea.
Il mio scopo, quindi, non consiste nel separare definitivamente Gesù e Cristo distruggendo la loro bimillenaria simbiosi, come molti hanno fatto e continuano a fare; consiste piuttosto nel separarli per poi ricostruirne la simbiosi su basi nuove, in modo che torni a essere accettabile per la coscienza contemporanea. È come se si trattasse di una delicata operazione chirurgica nella nostra interiorità per la quale prima si deve usare il bisturi per aprire e dividere, poi l’ago e il filo per ricucire e richiudere. Sono convinto infatti di due cose: che il modo tradizionale della configurazione di quella simbiosi oggi per noi non è più sostenibile; ma che di essa, in quanto unione di Storia e Idea, noi abbiamo strutturalmente bisogno.
Abbiamo bisogno sia dell’esattezza della Storia sia della speranza dell’Idea; abbiamo bisogno sia di sapere come andarono realmente le cose, sia di sapere come farle andare avanti noi qui e ora, trovando le energie necessarie alla mente e al cuore. La Storia senza l’Idea veicolata dal mito (non solo in ambito religioso ma anche filosofico e politico) è un insieme di pietre scomposte simili ai ruderi di un sito archeologico abbandonato; l’Idea senza la Storia è calce viva che brucia gli occhi causando cecità e superstizione. È solo dall’unione di pietre e di calce che si può costruire la casa della mente che ha bisogno di capire e al contempo la casa del cuore che ha bisogno di sperare. Il compito della storiografia è di generare comprensione, il compito della teologia è di generare speranza; ma occorre che quest’ultima lo faccia in modo compatibile con la comprensione acquisita.
Gesù è storia, Cristo è idea: i due personaggi e i rispettivi ambiti vanno rigorosamente distinti, ma al contempo armoniosamente integrati.





