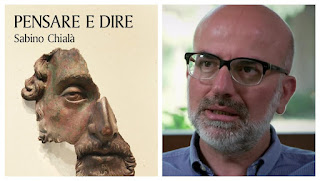Sabino Chialà "La parresia possibile e i suoi tratti"
|
|
|
|
|
|
|
L’esempio di Gesù e le varie attestazioni di
parresia osservate nelle vicende degli altri personaggi del nt su evocati interrogano ora la nostra
capacità di parresia. Raccogliendo quanto fin
qui osservato, cerchiamo di rispondere ad alcune
domande. Innanzitutto circa la parresia possibile
agli esseri umani, e in primo luogo nelle relazioni
interpersonali. Si tratta di dire la verità e di dirsi la verità. Ma questo è umanamente possibile?
E poi: quale verità? Ricordiamo la domanda di
Pilato a Gesù risuonata, senza ottenere risposta,
durante l’interrogatorio prima della condanna a
morte: “Cos’è la verità?” (Gv 18,38). O la già
menzionata riflessione di Dietrich Bonhoeffer:
“Cosa significa dire la verità?”.
Per i cristiani la verità non consiste in un
insieme di concetti, ma in una persona, il messia Gesù, che di sé ha detto, secondo il quarto vangelo: “Io sono la via, la verità e la vita”
(Gv 14,6). Una persona che non comprenderemo
mai pienamente, cui è possibile accostarsi solo in
un cammino progressivo condotto sotto la guida
dello Spirito santo, come egli stesso ha detto ai
suoi discepoli:
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da
sé stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà (Gv 16,13-14).
Per i cristiani dunque la verità è il Cristo,
che lo Spirito santo svela giorno dopo giorno,
nel loro andare verso il Regno. Non si tratta di
un possesso, ma di un cammino sotto la guida
dello Spirito.
Queste brevi considerazioni sul tenore della
verità in una prospettiva cristiana suggeriscono
una prima esigenza della parresia nei rapporti interpersonali: la consapevolezza che la verità non sarà mai posseduta in modo totale e definitivo,
essendo sempre oltre qualsiasi comprensione. Le
verità umane sono solo approssimazioni, e dunque perfettibili.
Una seconda qualità della verità è che essa si
inscriva in una relazione viva, come dice Romano Guardini:
Non esiste la “pura” veracità; essa sarebbe dura e si muterebbe in ingiustizia da sé. Ciò che
esiste è la veracità vivente.
La verità non si dice entro uno spazio vuoto, ma in direzione dell’altro; perciò chi la dice deve anche sentire che cosa essa, nell’altro,
provoca (1).
Essenziale, nell’esercizio della parresia, è la
qualità della relazione che sottostà alle parole.
A volte si proferiscono parole “oggettivamente” vere, ma che non nascono da un’onestà di
fondo, non scorrono in un alveo di sincerità
di sentimenti, non tengono conto del “bene” dell’altro, e infine non si preoccupano neppure
degli effetti che produrranno, perché non sono sostenute da una relazione autentica. Ebbene, in tutti questi casi, cose oggettivamente
vere sono false perché viziate in radice. Non
sono espressione di parresia, ma di sfrontatezza
e, dunque, equivalgono a menzogna. Un contesto menzognero, cioè contrappositivo e di non
rispetto dell’altro, rende menzognere anche le
parole più vere.
Bonhoeffer nel saggio che più volte abbiamo
citato scrive:
Il nostro parlare dev’essere veritiero non in linea di principio, ma in pratica. Una veracità
astratta, non è veritiera dinanzi a Dio …
Bisogna dunque imparare a dire la verità. Queste parole suoneranno scandalose per chi pensa che sia sufficiente un atteggiamento morale
irreprensibile e che il resto è cosa da nulla (2).
E poco oltre:
Ogni parola che pronuncio dev’essere vera; a
parte la veridicità del suo contenuto, il rapporto
che essa esprime tra me e l’altra persona è vero
o falso. Posso adulare, vantarmi, essere ipocrita,
senza dire una vera bugia, eppure la mia parola
è falsa perché io distruggo e dissolvo la realtà
del rapporto (3).
Tenere conto dell’altro, della qualità della relazione che con lui si intrattiene, è ciò che rende
alla parola la possibilità di essere detta con una
parresia legittima, che non significa evitare a tutti i costi di spiacere l’altro. La parresia è spesso
energica e può anche ferire – come osserviamo
nelle parole di Gesù narrateci dai vangeli che
scuotono e a volte scandalizzano l’uditorio –,
ma nasce sempre da un reale desiderio di bene
dell’altro e non da un bisogno di vendetta.
Di qui, un’ulteriore esigenza nell’esercizio della parresia: la necessaria distinzione tra “pudore” o “misura”, che è espressione del necessario
rispetto per l’altro, e “omissione”. Non è possibile sottrarsi alla difficile domanda se i nostri
silenzi sono espressione di rispetto oppure comoda e colpevole omissione, una delle mancanze più difficili da discernere, eppure così gravida di conseguenze, che spesso si rivelano molto
tempo dopo e diventano sempre più brucianti
con il passare degli anni. Ciò che non si è detto né fatto per pusillanimità, per quieto vivere,
per ipocrisia, per non inimicarsi l’altro, con il
tempo emerge con tutto il suo peso, ben più di
ciò che si è fatto sbagliando, soprattutto quando l’omissione è stata causa di male per la vita
di altri. Finché il male non denunciato ha ferito
solo colui che l’ha taciuto, ciò può sempre essere
letto come un esercizio di carità evangelica da
parte di chi sa porgere l’altra guancia, ma quando si tratta di un male che ha ferito altri non ci
sono attenuanti.
La parresia, dunque, necessita di un costante
esercizio di discernimento, altro requisito di cui
tenere conto. Un discernimento che metta alla
prova il cuore per scandagliare e mettere a nudo i
sentimenti che muovono parole e silenzi, se cioè
essi sono per l’altro o contro di lui. Se alla loro radice vi è sincero desiderio di comunicazione
nel bene, oppure vi sono lusinga, adulazione,
ipocrisia, reticenza o addirittura menzogna e desiderio di vendetta.
Tale discernimento ha da sondare la qualità
dei sentimenti di chi intende esercitare la parresia, se persegue il proprio interesse personale
oppure la verità possibile insieme all’altro. Una
domanda cruciale su cui misurare la qualità della
parresia riguarda ciò che sta davvero a cuore, se
il desiderio di salvare sé stessi e di far prevalere
il proprio pensiero o quello di salvare la comunione. Soprattutto in un’esperienza comunitaria,
la mancanza di parresia può anche esprimersi in
silenzi che sanno di rifiuto e in parole che sanno
di manipolazione.
L’esercizio della parresia è dunque possibile
e necessario tra esseri umani, poiché senza il
coraggio e la libertà di dirsi la verità non è possibile una relazione autentica. Si tratta di un
irrinunciabile atto di responsabilità, in quanto
dove essa è taciuta in modo colpevole avanzano
l’ingiustizia e la violenza. Ma una verità che abbia i tratti qui brevemente evocati: che sia cioè
consapevole del proprio limite, che si inscriva
in una relazione viva e autentica, che sia capace di dosare silenzio e parola, e infine che sia
disposta a sondare la qualità dei sentimenti da
cui è mossa.
Note:
1) Citato in A. Gallas, “Dire la verità”, in Servitium III s. 28 (1983),
p. 8.
2) D. Bonhoeffer, Cosa significa dire la verità?, p. 310.
3) Ibid., pp. 310-311.
AUTORE
Sabino Chialà (Locorotondo 1968) è monaco e priore di Bose dal 2022 a oggi. Studioso di ebraico e siriaco, si è dedicato in particolare allo studio della figura e dell’opera di Isacco di Ninive, di cui ha recentemente pubblicato la prima traduzione italiana completa della prima collezione dei suoi scritti.